|
|
|
|
|
|
Itinerario
poetico di Montale
di
Emerico Giachery
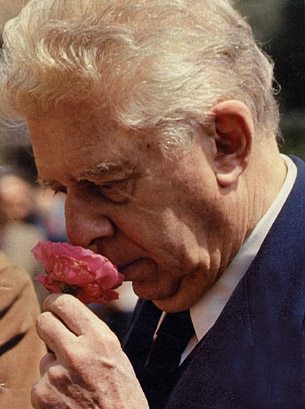 Montale
stesso invita il lettore a considerare la sua opera poetica "nella sua
totalità", come un organico itinerario di esperienza conoscitiva ed
espressiva scandito in tempi, articolato in successivi sviluppi. Sarà
proficuo seguire il suo consiglio, ripercorrendo in sintesi l'intero
cammino, tenendo conto delle grandi tappe, dei momenti fondamentali.
La Liguria dell'infanzia e della giovinezza (nato a Genova il l2 ottobre
1896, Montale trascorre le prime trenta estati della sua vita nella
vasta villa paterna a Monterosso nelle Cinque Terre) offre alla sua
prima poesia il costitutivo teatro di un paesaggio intenso di grandi
luci estive e di inquieti orizzonti marini: paesaggio, secondo una definizione
dello stesso poeta, "universalissimo". Cioè atto ad evocare universali,
elementari simboli dell'esistenza e della condizione umana, e segnali
di una concezione del mondo maturata in solitudine attraverso assidue
letture di scrittori europei classici e moderni, di testi religiosi
(anche vicini al modernismo) e filosofici (per esempio di Schopenhauer,
di Bergson e specialmente di Boutroux). Montale
stesso invita il lettore a considerare la sua opera poetica "nella sua
totalità", come un organico itinerario di esperienza conoscitiva ed
espressiva scandito in tempi, articolato in successivi sviluppi. Sarà
proficuo seguire il suo consiglio, ripercorrendo in sintesi l'intero
cammino, tenendo conto delle grandi tappe, dei momenti fondamentali.
La Liguria dell'infanzia e della giovinezza (nato a Genova il l2 ottobre
1896, Montale trascorre le prime trenta estati della sua vita nella
vasta villa paterna a Monterosso nelle Cinque Terre) offre alla sua
prima poesia il costitutivo teatro di un paesaggio intenso di grandi
luci estive e di inquieti orizzonti marini: paesaggio, secondo una definizione
dello stesso poeta, "universalissimo". Cioè atto ad evocare universali,
elementari simboli dell'esistenza e della condizione umana, e segnali
di una concezione del mondo maturata in solitudine attraverso assidue
letture di scrittori europei classici e moderni, di testi religiosi
(anche vicini al modernismo) e filosofici (per esempio di Schopenhauer,
di Bergson e specialmente di Boutroux).
Pienamente immerso nel paesaggio ligure, e in gran parte "all'aria aperta"
e accompagnato dal "delirio del mare", segnato ma non sopraffatto da
un intimo rovello filosofico, il suo libro iniziale, Ossi di seppia,
è già un capolavoro, uno dei libri-chiave del Novecento poetico. Apparve
in prima edizione nel 1925, in seconda edizione accresciuta di alcune
importanti poesie, nel 1928.Al 1916 risale la prima redazione del testo
più antico della raccolta, che comincia coi versi famosi "Meriggiare
pallido e assorto / presso un rovente muro d'orto", già portatori di
alcuni segni-simboli fondamentali del libro (come l'ora meridiana, il
muro, l'orto), e che si conclude non meno significativamente: "E andando
nel sole che abbaglia / sentire con triste meraviglia / com'è tutta
la vita e il suo travaglio / in questo seguitare una muraglia /che ha
in cima cocci aguzzi di bottiglia". (Si noti l'asprezza anche fonica
dell'immagine finale, inserita nella tonalità caratteristica della cosiddetta
"linea ligure" della poesia italiana del Novecento). Il senso angoscioso
di una chiusura e costrizione esistenziale (il muro, appunto, che compare
in diversi testi, la "rete che ci stringe", la "ferrea catena della
necessità", la "catena che ci lega", la "giostra d'ore troppo uguali"
della ripetizione banale) domina l'immaginario del primo libro. Vi si
oppone la ricerca di sperati spiragli di libertà e di vita autentica:
la "maglia rotta" nella rete, "l'anello che non tiene", la "lima che
sega" la catena, l'inaspettato prodigio che salva (il "miracolo laico"),
di cui è portatrice o nunzia l'immagine femminile, che assumerà nei
due libri seguenti la fondamentale funzione di una moderna e laica Beatrice.
Laica, non però disancorata dalla dimensione del sacro e dell'oltre.
 Nella
seconda edizione di Ossi di seppia compare un testo- chiave, Arsenio,
in cui il poeta condensa gli elementi che caratterizzano il "personaggio
che dice io" in questo primo libro. Arsenio, in parte alter ego di Montale
(non certo per caso in rima con Eugenio), reincarna il tipico eroe negativo,
o antieroe, romantico o decadente, da René di Chateaubriand all'"inetto"
di Svevo, del quale proprio in quegli anni Montale scopriva e proclamava,
primo forse tra gli italiani, la grandezza. Arsenio è incapace di vivere,
la sua tantalica sete di uscire dalla banalità, di aprirsi alla vita
autentica cade nel vuoto. Il secondo libro, Le occasioni, esce in prima
edizione in un anno funesto per il destino d'Europa, il 1939.Presagi
dell'immane tragedia, non tanto espliciti quanto di "atmosfera", si
potrebbero reperire in alcune delle splendide poesie conclusive, senza
però dimenticare che una certa vocazione "apocalittica" è presente anche
altrove . Primo nucleo del libro è la raccoltina La casa dei doganieri
e altri versi, in cui ancora compare il motivo del "varco". Nel cuore
del libro troviamo i Mottetti, piccolo canzoniere d'amore profondamente
originale e moderno, incentrato nel tema della lontananza, dell'assenza.
Un critico che di Montale fu commilitone e amico, Sergio Solmi, per
far meglio capire il passaggio dal primo libro al secondo, dall'autobiografismo
"universalistico", "esemplare" della giovinezza alla dimensione di un
destino personale, carico di segreto, ombre, reticenze, proprio della
maturità ricorre a una pertinente citazione da Rilke: "più andiamo lontano,
e più personale, più unica si fa la vita". Anche il paesaggio muta dopo
che il poeta si trasferisce a Firenze: non più la dismisura irrequieta
del mare di Liguria, ma la misura "umanistica" delle armoniose colline,
peraltro molto raramente presenti nella pagina, nella quale invece di
solito compaiono paesaggi quasi casuali, spesso colti di scorcio, con
immagini fulminee: "figure d'album d'un involontario turista smarrito
quaggiù, intento a cogliervi il momentaneo geroglifico del suo transito
terrestre". Così Solmi, il quale continua: "Quei paesaggi sono l'affiorare
della complessa architettura di un destino di cui indoviniamo un'arcata
mozza, un tronco, un frammento, di colpo illuminati come da una lanterna
cieca in una cripta". Queste parole possono giovare a intendere la poetica
di Montale al tempo delle Occasioni, la sua ricerca di una poesia simile
(a detta dello stesso poeta) "a un frutto che dovesse contenere i suoi
motivi senza rivelarli, o meglio senza spiattellarli. Ammesso che in
arte esista una bilancia tra il di fuori e il di dentro, tra l'occasione
e l'opera-oggetto bisognava esprimere l'oggetto e tacere l'occasione-spinta.
Un modo nuovo, non parnassiano, di immergere il lettore in medias res,
un totale assorbimento delle intenzioni nei risultati oggettivi". Nella
seconda edizione di Ossi di seppia compare un testo- chiave, Arsenio,
in cui il poeta condensa gli elementi che caratterizzano il "personaggio
che dice io" in questo primo libro. Arsenio, in parte alter ego di Montale
(non certo per caso in rima con Eugenio), reincarna il tipico eroe negativo,
o antieroe, romantico o decadente, da René di Chateaubriand all'"inetto"
di Svevo, del quale proprio in quegli anni Montale scopriva e proclamava,
primo forse tra gli italiani, la grandezza. Arsenio è incapace di vivere,
la sua tantalica sete di uscire dalla banalità, di aprirsi alla vita
autentica cade nel vuoto. Il secondo libro, Le occasioni, esce in prima
edizione in un anno funesto per il destino d'Europa, il 1939.Presagi
dell'immane tragedia, non tanto espliciti quanto di "atmosfera", si
potrebbero reperire in alcune delle splendide poesie conclusive, senza
però dimenticare che una certa vocazione "apocalittica" è presente anche
altrove . Primo nucleo del libro è la raccoltina La casa dei doganieri
e altri versi, in cui ancora compare il motivo del "varco". Nel cuore
del libro troviamo i Mottetti, piccolo canzoniere d'amore profondamente
originale e moderno, incentrato nel tema della lontananza, dell'assenza.
Un critico che di Montale fu commilitone e amico, Sergio Solmi, per
far meglio capire il passaggio dal primo libro al secondo, dall'autobiografismo
"universalistico", "esemplare" della giovinezza alla dimensione di un
destino personale, carico di segreto, ombre, reticenze, proprio della
maturità ricorre a una pertinente citazione da Rilke: "più andiamo lontano,
e più personale, più unica si fa la vita". Anche il paesaggio muta dopo
che il poeta si trasferisce a Firenze: non più la dismisura irrequieta
del mare di Liguria, ma la misura "umanistica" delle armoniose colline,
peraltro molto raramente presenti nella pagina, nella quale invece di
solito compaiono paesaggi quasi casuali, spesso colti di scorcio, con
immagini fulminee: "figure d'album d'un involontario turista smarrito
quaggiù, intento a cogliervi il momentaneo geroglifico del suo transito
terrestre". Così Solmi, il quale continua: "Quei paesaggi sono l'affiorare
della complessa architettura di un destino di cui indoviniamo un'arcata
mozza, un tronco, un frammento, di colpo illuminati come da una lanterna
cieca in una cripta". Queste parole possono giovare a intendere la poetica
di Montale al tempo delle Occasioni, la sua ricerca di una poesia simile
(a detta dello stesso poeta) "a un frutto che dovesse contenere i suoi
motivi senza rivelarli, o meglio senza spiattellarli. Ammesso che in
arte esista una bilancia tra il di fuori e il di dentro, tra l'occasione
e l'opera-oggetto bisognava esprimere l'oggetto e tacere l'occasione-spinta.
Un modo nuovo, non parnassiano, di immergere il lettore in medias res,
un totale assorbimento delle intenzioni nei risultati oggettivi".
Come Arsenio, secondo Montale, rappresenta una cerniera tra il primo
e il secondo libro, così Nuove stanze, del '39, può considerarsi una
cerniera tra Le occasioni e Finisterre, primo nucleo del terzo libro,
La bufera e altro (1956), forse il più alto e certo il prediletto dal
poeta, ma scarsamente compreso al suo apparire. In Nuove stanze l'atmosfera
della guerra ormai alle porte è molto più esplicita che altrove, ed
è significativo che si apra una finestra "non vista", e nella sfera
del privato, rappresentata dal chiuso di una stanza, penetri minacciosa,
allarmante, la Storia, la "tregenda" di un destino comune. Finisterre
(quasi finis terrae come finis Europae, minacciata fine di una certa
Europa umanistica e illuminata) esce in prima edizione a Lugano in piena
guerra, come "un'appendice alle Occasioni, per gli amici che non vorrebbero
fermarsi e far punto a quel libro". E ancora: "Le Occasioni erano un'arancia,
o meglio un limone a cui mancava uno spicchio: non proprio quello della
poesia pura nel senso che ho indicato prima [ossia non come gioco di
suggestioni sonore ma come nascondimento dell'occasione- spinta], ma
in quello del pedale, della musica profonda e della contemplazione.
Ho completato il mio lavoro con le poesie di Finisterre, che rappresentano
la mia esperienza, diciamo così, petrarchesca. Ho proiettato la Sevaggia
o la Mandetta o la Delia dei Mottetti sullo sfondo di una guerra cosmica
e terrestre, senza scopo e senza ragione, e mi sono affidato a lei,
donna o nube, angelo o procellaria.[...] Si tratta di poche poesie,
nate nell'incubo degli annì40-42,forse le più libere che io abbia
mai scritto". A proposito del titolo del terzo libro, Montale scrive:
"La bufera è la guerra, in ispecie quella guerra dopo quella dittatura;
ma è anche guerra cosmica, di sempre e di tutti". Su quell'anche sottolineato
da Montale, e che compare in altre significative pagine di autocommento,
è opportuno soffermarsi perché offre una chiave di lettura, rimanda
al cuore di una poetica, che vuol conservare la ricchezza di sensi e
di piani, la natura aperta della parola lirica. Oltre a continuare l'esplorazione
di immagini del mondo e dell'esistenza colte nella "eternità d'istante"
di una "luce di lampo", il terzo libro sviluppa con ammirevoli esiti
il tema della memoria, già felicemente presente nel grande notturno
di Vecchi versi che apriva Le occasioni. Sullo sfondo disumano di una
guerra totale, l'amorevole pietas per le memorie personali e familiari
può rappresentare un'intatta isola di squisita umanità. Una poesia che
tende, sia pure in modo indiretto, a fondare una città dell'uomo come
luogo di civiltà spirituale, di misura umana, di aristocratica elettezza,
di rifiuto della banalità, trova nel personaggio femminile adombrato
sotto il nome di Clizia (oceanina amata da Apollo e trasformata in girasole,
creatura fedele e solare) un centro di irradiazione, un vivo ed intenso
emblema. (Nella Bufera compare anche un personaggio femminile non angelicato,
denominato la Volpe, al centro della sezione intitolata Madrigali privati).
L'ultimo Montale segna una netta svolta nel cammino. Nel l971 appare
Satura (di cui alcune parti erano state pubblicate in anni precedenti).Nel
1973, Diario del '71 e del '72. Nel l977, Quaderno di quattro anni.
Nel 198l, anno della sua morte (avvenuta a Milano il 12 settembre),
vedono la luce Altri versi e poesie disperse. Non va dimenticato, anche
se questo ragguaglio concerne soltanto l'opera poetica, che Montale
ci ha lasciato un'imponente opera in prosa (ora raccolta in quattro
grossi volumi dei "Meridiani" di Mondadori),che comprende i finissimi
racconti di Farfalla di Dinard, le felici prose di viaggio intitolate
Fuori di casa, scritti saggistici, di critica letteraria, musicale e
di costume, che documentano la lunga e assidua attività di giornalista.
Nell'insieme dell'opera in versi di Montale successiva alla Bufera gli
studiosi hanno tentato di operare distinzioni (un posto a parte occupa
in Satura la serie degli Xenia, affettuoso colloquio, fondato sulle
dimesse e tenere rievocazioni del quotidiano, con la moglie morta).
 Ma
resta possibile considerare quella produzione piuttosto ampia, e ricca
di varianti più di quanto si possa immaginare, come un tutto relativamente
omogeneo con alcuni punti di forza. La tensione lirica è ora o totalmente
assente o dissimulata con abilità: il poeta ama ora mostrarsi "in pigiama",
abitare "a pianterreno", abbandonare la pittura di cavalletto per un'"arte
povera", frequentare e lasciar intravedere il "retrobottega" . Egli
stesso ci dice: "ho scritto un solo libro, di cui prima ho dato il recto,
ora do il verso". Materia di scrittura sono molto spesso spunti di cronaca
e di polemica, avvii riflessivi o discorsivi anche minimi. Il linguaggio
è prosastico, trito, spesso volutamente sciatto, ma in realtà per lo
più frutto di notevole, sorniona scaltrezza espressiva. Frequente la
riduzione autoparodica di trascorsi e sintomatici momenti "alti" della
propria poesia, il condimento dell'humour, il gioco col significante,
quasi a suggerire il senso di una disincantata saggezza: "La mia Musa
è lontana: si direbbe / (è il pensiero dei più) che mai sia esistita.
/ Se pure una ne fu, indossa i panni dello spaventacchio / alzato a
malapena su una scacchiera di viti". Ed ecco la conclusione: "La mia
Musa ha lasciato da tempo un ripostiglio / di sartoria teatrale; ed
era d'alto bordo / chi di lei si vestiva. Un giorno fu riempita / di
me e ne andò fiera. Ora ha ancora una manica / e con quella dirige un
suo quartetto / di cannucce. È la sola musica che sopporto".
Non è possibile concludere questo rapido e compendioso itinerario della
poesia di Montale tralasciando di parlare del discusso Diario postumo,
che nel volume apparso (con apparato critico di Rosanna Bettarini )
nella mondadoriana collana "I classici dello Specchio" per il centenario
della nascita del poeta comprende ottantaquattro poesie inedite. Questo
singolare libro (del quale recentemente Dante Isella, in polemica con
gli altri studiosi, ha messo in dubbio l'autenticità) è stato voluto
dall'autore vivo e operante, che ha affidato i testi, a condizione però
che fossero pubblicati post mortem, alle cure della poetessa Annalisa
Cima. Le date di composizione di essi vanno dal 1969 al 1979.Il tono,
pacatamente colloquiale, non è molto diverso da quello dominante in
tutto l'"ultimo" Montale, anche se le frequenti autocitazioni di antichi
segni non sembrano quasi mai caratterizzate da intenti di riduzione
parodica. Vi è diffuso un clima di affettuosa amicizia che trasforma
il libro in un ideale falansterio di amici animato dall'armoniosa presenza
femminile di Annalisa che ne è il centro. Così il poeta ha voluto, in
modo davvero inaspettato e tutt'altro che convenzionale e accademico,
rinverdire, dal mistero dell'Oltrevita, la sua sorridente presenza tra
amici e lettori. "Nell'aldilà mi voglio divertire": così suona un verso
del libro volutamente postumo. Ma
resta possibile considerare quella produzione piuttosto ampia, e ricca
di varianti più di quanto si possa immaginare, come un tutto relativamente
omogeneo con alcuni punti di forza. La tensione lirica è ora o totalmente
assente o dissimulata con abilità: il poeta ama ora mostrarsi "in pigiama",
abitare "a pianterreno", abbandonare la pittura di cavalletto per un'"arte
povera", frequentare e lasciar intravedere il "retrobottega" . Egli
stesso ci dice: "ho scritto un solo libro, di cui prima ho dato il recto,
ora do il verso". Materia di scrittura sono molto spesso spunti di cronaca
e di polemica, avvii riflessivi o discorsivi anche minimi. Il linguaggio
è prosastico, trito, spesso volutamente sciatto, ma in realtà per lo
più frutto di notevole, sorniona scaltrezza espressiva. Frequente la
riduzione autoparodica di trascorsi e sintomatici momenti "alti" della
propria poesia, il condimento dell'humour, il gioco col significante,
quasi a suggerire il senso di una disincantata saggezza: "La mia Musa
è lontana: si direbbe / (è il pensiero dei più) che mai sia esistita.
/ Se pure una ne fu, indossa i panni dello spaventacchio / alzato a
malapena su una scacchiera di viti". Ed ecco la conclusione: "La mia
Musa ha lasciato da tempo un ripostiglio / di sartoria teatrale; ed
era d'alto bordo / chi di lei si vestiva. Un giorno fu riempita / di
me e ne andò fiera. Ora ha ancora una manica / e con quella dirige un
suo quartetto / di cannucce. È la sola musica che sopporto".
Non è possibile concludere questo rapido e compendioso itinerario della
poesia di Montale tralasciando di parlare del discusso Diario postumo,
che nel volume apparso (con apparato critico di Rosanna Bettarini )
nella mondadoriana collana "I classici dello Specchio" per il centenario
della nascita del poeta comprende ottantaquattro poesie inedite. Questo
singolare libro (del quale recentemente Dante Isella, in polemica con
gli altri studiosi, ha messo in dubbio l'autenticità) è stato voluto
dall'autore vivo e operante, che ha affidato i testi, a condizione però
che fossero pubblicati post mortem, alle cure della poetessa Annalisa
Cima. Le date di composizione di essi vanno dal 1969 al 1979.Il tono,
pacatamente colloquiale, non è molto diverso da quello dominante in
tutto l'"ultimo" Montale, anche se le frequenti autocitazioni di antichi
segni non sembrano quasi mai caratterizzate da intenti di riduzione
parodica. Vi è diffuso un clima di affettuosa amicizia che trasforma
il libro in un ideale falansterio di amici animato dall'armoniosa presenza
femminile di Annalisa che ne è il centro. Così il poeta ha voluto, in
modo davvero inaspettato e tutt'altro che convenzionale e accademico,
rinverdire, dal mistero dell'Oltrevita, la sua sorridente presenza tra
amici e lettori. "Nell'aldilà mi voglio divertire": così suona un verso
del libro volutamente postumo.

(© 1995 Copyright Sun.Moon.Lake@agora.stm.it)
|
|

