|
|
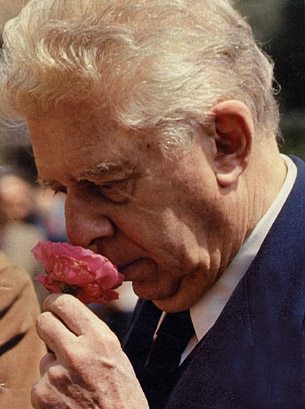 Restringere
la tematica montaliana del "male di vivere" all'ordine filosofico significherebbe
ridurre l'esperienza poetica dell'autore ad una matrice meramente intellettuale,
causando, a mio avviso, un impoverimento contenutistico dal punto di
vista umano. L'uomo Montale che sente l'angoscia esistenziale di un
animo informe, incapace di essere un tutt'uno con l'armonia cosmica,
che cerca invano la maglia rotta, l'anello che non tiene, il filo da
disbrogliare che finalmente lo porti nel mezzo di una verità, è l'uomo
di sempre che, più o meno sensibile, nella sua umanità, sente di non
essere in sintonia con il mondo, anzi, spesso, di esservi soggetto in
modo terribile e crudele. Considerare esclusivo questo sentimento di
angoscia sarebbe un errore, considerare esclusiva la lucidità, la chiara
presa di coscienza ed il coraggio di porsi di fronte a tale angoscia
una giusta valutazione. Restringere
la tematica montaliana del "male di vivere" all'ordine filosofico significherebbe
ridurre l'esperienza poetica dell'autore ad una matrice meramente intellettuale,
causando, a mio avviso, un impoverimento contenutistico dal punto di
vista umano. L'uomo Montale che sente l'angoscia esistenziale di un
animo informe, incapace di essere un tutt'uno con l'armonia cosmica,
che cerca invano la maglia rotta, l'anello che non tiene, il filo da
disbrogliare che finalmente lo porti nel mezzo di una verità, è l'uomo
di sempre che, più o meno sensibile, nella sua umanità, sente di non
essere in sintonia con il mondo, anzi, spesso, di esservi soggetto in
modo terribile e crudele. Considerare esclusivo questo sentimento di
angoscia sarebbe un errore, considerare esclusiva la lucidità, la chiara
presa di coscienza ed il coraggio di porsi di fronte a tale angoscia
una giusta valutazione.L'itinerario poetico di Montale ci porta verso l'approfondimento di una visione della vita e di una concezione dell'esistenza che propone tematiche fondamentalmente ricorrenti, ma analizzate in modo sempre più razionale e lucido. La poesia, in questo contesto tematico, in questa cupa e pessimistica visione del mondo, non può indicare la strada per uscire dalla crudele morsa del mondo (Non domandarci la formula che mondi possa aprirti), poiché è venuto meno il suo potere conoscitivo ed interpretativo del reale, a causa della perdita, da parte del soggetto, della fiducia nella possibilità di una corrispondenza logica ed analogica tra significante e significato, tra io e mondo. In questa disarmonia, in questo disaccordo, la poesia può essere soltanto rappresentazione di un universo smembrato, ridotto ad un ammasso di detriti, ad un inventario di oggetti privi di relazione tra loro e con il soggetto (La vita è questo scialo di triti fatti). La poesia può solo offrire "qualche storta sillaba e secca come un ramo", può solo rappresentare questa condizione negativa, rinvenendola negli oggetti attraverso il correlativo oggettivo eliottiano. La poesia è ancora il risultato della consapevolezza della negatività, di questo non essere dell'uomo ("Codesto solo oggi possiamo dirti / ciò che non siamo, ciò che non vogliamo") , di questa informità dell'animo, è testimonianza visiva di una negatività dialettica che porta il poeta a tendere verso una positività, ma che sempre si rivela inaccessibile all'uomo, forse proprio perché inesistente. Negli "Ossi di seppia" tale negatività dialettica è riscontrabile nel medesimo titolo della raccolta: gli ossi rappresentano il correlativo oggettivo della condizione dell'uomo, ridotto appunto a rifiuto, ad inutile rottame dell'esistenza, espulso, esiliato dalla vita, quella reale, quella autentica, quella vera, quella rappresentata dal mare ("Ti guardiamo noi, della razza / di chi rimane a terra"). La tematica del detrito comporta un sentimento di scacco e di fallimento esistenziale e sociale, ma non esclude totalmente un riscatto, un appiglio, una salvezza.Ma dove trovare questo appiglio, dove rintracciare una qualche piccola possibilità di salvezza? Paradossalmente proprio nella condizione di rifiuto, proprio nella diversità che tale condizione determina:la leggerezza. Solo grazie a questa l'osso potrà galleggiare sulle onde e confondersi con la natura, con l'armonia cosmica e diventare quasi parte di questa, perché in fondo è questo il tormento dell'uomo, non poter essere in armonia con il cosmo, non poter aderire panicamente e completamente alla natura Potessi almeno costringere in questo mio ritmo stento qualche poco del tuo vaneggiamento; dato mi fosse accordare alle tue voci il mio balbo parlare. (Mediterraneo)
Cerca una maglia rotta nella rete che ci stringe, tu balza fuori, fuggi! Va, per te l'ho pregato, - ora la sete mi sarà lieve, meno acre la ruggine.
Ogni possibilità di salvezza, di miracolo, di prodigio, è affidata ad una memoria fragile, desultoria ed involontaria, che difficilmente riuscirà ad assolvere la propria funzione Non recidere forbice, quel volto, solo nella memoria che si sfolla, non far del grande suo viso in ascolto la mia nebbia di sempre. (Non recidere, forbice, quel volto..) ad una memoria inadeguata ed arbitraria: è lei che decide chi deve apparire in ricordo e chi no, è lei che delinea l'immagine ridente nel puro cerchio, è lei che poi deforma il passato, lo fa vecchio, lo dona ad un altro e ridona al fondo la visione, rendendola distante. È questa, dunque, una memoria che ha come sua pare fondante l'oblio e che da questo è regolata e resa crudele, poiché non solo impone ciò che è indesiderato, ma sottrae anche il ricordo desiderato. Questa crudeltà è propria di una memoria quale è presente negli "Ossi di seppia", grigia, stanca, scialba, dilavata e terribile ("Nasceva in noi, volti dal cieco caso, / oblio del mondo.", ".e ora nella scialba memoria,."). Lo stesso Proust, che fu oggetto di particolare attenzione da parte di Montale, nella "Fuggitiva" parla di una legge generale dell'oblio; ma la memoria proustiana è un rimedio a questo oblio, o meglio un antidoto al "male di vivere", e a tutto ciò che ne è la causa, prima fra tutte la "fuite du temps", tipica di tuta la tradizione letteraria francese e non solo.La memoria proustiana è ancora involontaria, arbitraria, dipendente da stimolazioni sensoriali non controllate dall'uomo, ma è anche il punto di partenza verso l'eternità personale, verso la sottrazione al tempo di un sé ritrovato.Non a caso la "Recherche du temps perdu" è proprio il romanzo dell'illusione temporale, nel quale l'arte è vista come l'unica salvezza dalla dissipazione dell'io; la memoria è capace di spezzare le corde che tengono l'uomo legato alla contingenza spaziale e temporale, inserendolo in una dimensione senza tempo e spazio, senza un "prima" ed un "poi", senza un "fu" ed un "sarà", ma soltanto con un "è", soltanto con un flusso continuo che porta paradossalmente alla stabilità, con una rivelazione che offre la durata bergsoniana del tempo. Montale parte da basi proustiane per giungere però solo alla fase distruttiva, al niente, senza approdare all'alternativa del "bello" dello scrittore francese. Al misticismo della Recherche ha sostituito uno stoicismo fero e lucido che, seccamente ed in maniera totalmente disillusa, non dimentica che il primum resta, leopardianamente, l'esistenza e non l'arte, il tempo ed il scorrere, non la durata. Tra Proust e Montale, come tra epifania e concretezza, arte e vita, si pone come incontro, come nuova e allo stesso tempo comune formulazione di pensiero e capacità di sentimento, Virginia Woolf, con i suoi disperati e profondi interrogativi: "Quale è il senso della vita?.La grande rivelazione non sarebbe giunta mai. Era sostituita da piccoli miracoli quotidiani, illuminazioni, fiammiferi accesi improvvisamente nel buio..il ricordo di quei labili episodi. In mezzo al caos era la forma. L'eterno transito, l'eterno flusso potevano configurarsi nella stabilità". E la stabilità era per Proust la durata, il Senso custodito nell'arte e quindi un sinonimo di salvezza; per Montale la stabilità era invece la vita, "questo scialo di triti fatti, vano più che crudele", quindi "male di vivere". I piccoli miracoli quotidiani della Woolf, quelle leggere illuminazioni, quei fiammiferi accesi nel buio, quei labili ma concreti episodi, possono essere la "madelaine" di Proust, i limoni gialli, il topo bianco d'avorio, il portacipria, gli orecchini, i piccoli oggetti luminosi nel buio montaliano. Ma i talismani non salvano l'uomo Montale, comunque destinato al male di vivere, come non lo salva la memoria, poiché questa non aiuta a fuggire dal tempo, ma facilita la fuga del tempo. Disillusione nella speranza, miracolo nella realtà, coraggio nella sofferenza, richiamo alla vita, all'energia nel pur radicato pessimismo; anche questa è la negatività dialettica di un Montale che si muove lungo una linea del pessimismo leopardiano, di quello, però contenente il momento antinegativo, riposto nella "fantasia di salvezza", sviluppata in una durata di apparizione di un fantasma, che è la sola affermazione di vitalità nella più arida nullità. Ed è infatti sulla scorta leopardiana che egli significa l'essenza, il nulla della memoria e della vita. Un nulla affrontato con l'orgoglio di una solitudine combattiva e persuasa, quasi rassegnata; un orgoglio fondato su di una esattezza e lucidità intellettuali che spingono Montale e lo stesso Leopardi ad essere poeti in quanto contro il proprio tempo. Il conflitto leopardiano con la contemporaneità storica è ancora ad un livello di presentimento e solo in Montale diviene malinconica certezza della fine dell'arte nel Kitsch universale; ed è per questo, infatti, che la poesia non è più incoronata a salvifica rivelatrice di verità. A Leopardi il primo Montale ritorna sempre per fierezza cosmico-negativa di un io giovane che senza intermediari luminosi, tragicamente, filosoficamente, interroga il mondo. La fede materialistica di Leopardi è assunta da Montale e giocata sul nesso necessità-caso, sul relativismo probabilistico e su di un esistenzialismo dell'assurdo e del miracolo, che va da Boutroux-Cestov a Svevo e Proust, per approdare alla distruzione paradossale dei quelle coerenza dell'io che risulta ancora intenzionata alla fermezza, la stessa che traspare chiaramente nei canti leopardiani. Una fermezza che approda ad un progetto stoico, senza escludere una speranza spesso negata, ma sempre presente; una speranza che esiste proprio perché l'uomo prova il "male di vivere", con il continuo timore di oltrepassare il bordo estremo del nulla e di approdavi.Ma stoicamente l'uomo Montale cerca di braccare il nulla, il "vuoto che ci invade", tenta di essere la "sirena dei mari freddi". Il dialogo impossibile, la salvezza mancata, sono dovuti ad uno scacco cosmico la cui percezione, ed in seguito, la cui piena consapevolezza arrivano a Montale, oltre che dalla sua mente attenta, riflessiva e sensibile al dolore umano, dai così detti "padri metafisici", ai quali il poeta si interessa e che legge mosso da un'attrattiva naturale, spontanea. Primi fra tutti Baudelaire e Browning; ad essi lo accomuna una concezione ed una professione di arte che non rinuncia alla ragione, ma che nasce proprio dal cozzo di questa con qualche cosa che non è la ragione, portando, così, alla creazione di quella che viene chiamata "arte metafisica". Baudelaire appare a Montale in tutta la sua lucidità ed in tutta la sua disperazione per un mancato approdo all'ideale tanto aspirato e ricercato attraverso i mezzi più svariati, i "paradisi artificiali"; ma questi sono tutti tentativi vani, come del resto lo sono i talismani montaliani.
A questo punto la cultura montaliana risulta essere ra le più stratificate del nostro secolo e quindi, a mio avviso, tra le più valide, proprio perché ricca di spunti, di punti di vista, di dimensioni umane, filosofiche e letterarie.Lo rivela anche il costante riferimento a tematiche filosofiche di Cestov, Schopenahuer, Boutroux. Nella sua costante lucidità, quasi scientifica per quanto tenace, ma sempre protesa verso un minimo di attesa salvifica, verso il miracolo epifanico, Montale ricorda chiaramente la difesa dell'assurdo e del miracolo di Cestov contro quella scienza e quelle coscienza comune che vorrebbero l'uomo circondato dal muro dell'evidenza e della stretta causalità, non libero di offrirsi liberamente al di là della "tonaca che riveste la nostra umana ventura": Cestov diffida di tale scienza, perché trasforma il contingente in necessario, e della legge kantiana della ragione stabilizzante.La vita pensata da Cestov vuole forse essere la stessa di Montale, a cui non chiedere "lineamenti / fissi, volti plausibili o possessi", una vita che plasmi un uomo che possa non dire "resto così questa scorza la mia vera sostanza". Niente di necessario, dunque, di determinato e di inevitabile; niente stabilità, solo il disordine che regoli questo nuovo mondo e quello di sempre. Il disordine come base dell'ordine e non viceversa (".il nostro mondo si regge appena"). Ed è proprio la scienza che porta a questa consapevolezza, perché man mano che procede nel suo cammino scopre nuovi sistemi prima inimmaginabili ed esclusivi, nuovi ordinamenti che rimettono in discussione i sistemi stabiliti in precedenza. A tale rimessa in discussione dei principi ordinatori corrisponde naturalmente la crisi dei processi e dei modelli conoscitivi, con una conseguente perdita di identità d parte dell'uomo e parcellizzazione dell'io che non smette mai di sorprendersi per le novità rivelateglisi al di fuori e dentro se stesso. Ma perché mai l'uomo dovrebbe sorprendersi, meravigliarsi? Non accadrebbe se pensasse come Boutroux, che nella sua "De la contingence des lois de la nature" cerca di eliminare ogni determinismo dalla natura, in polemica diretta con il positivismo; nella natura non si verifica il ripetersi dell'identico, l'effetto non si può mai dedurre dalla necessità, perché contiene in sé sempre qualcosa di nuovo rispetto alla causa ed è quindi contingente rispetto ad essa. Si capisce come la mente umana possa sentirsi smarrita ed impotente di fronte ad un mondo naturalmente contingente. Come pretendere, allora, da queste certezze, leggi, determinazioni fisse e costanti? Anche per Schopenahuer, fortemente echeggiante nel pensiero e nell'opera montaliana, il mondo non è frutto della ragione, ma di una volontà senza meta, di un impulso senza norma.In questo senso egli mostra una chiara opposizione al razionalismo ottimistico proprio di Hegel, sostituito da un volontarismo pessimistico. Il mondo per Shopenahuer è volontà e rappresentazione e come tale è negativo; è la volontà che ci spinge verso un mondo di cui noi conosciamo soltanto l'aspetto fenomenico, solo una rappresentazione attraente; ci sfugge l'aspetto numerico, il senso vero dell'universo, che è riposto nel dolore. Il piacere ci incatena alla vita, ma esso è solo un'illusione. Montale, senza dubbio, è esente da un tale inganno, così fermo nella consapevolezza di una rottura fra soggetto e mondo, inconoscibile e non ordinabile, di una lacerazione profonda fra realtà e soggettività che porta ad una completa disarmonia che soltanto il miracolo può sanare. Se pensiamo all'esistenzialismo montaliano non possiamo on rapportarlo a quello leopardiano; entrambi giungono ad una disillusa, lucida e razionalistica attitudine a non consolarsi, con un impatto sia sul piano dell'esistenza che della poesia.Quella di Montale è una lucidità fragile e tentennante, ma sempre costante, che respinge ogni sorta di misticismo, anche in forza di una caratterizzazione geografica, per il suo empirismo ligure, e di rinforzi letterari e filosofici di origine britannica. Ma lo stesso Montale era cosciente di una sua posizione filosofica non ben sorretta e tanto più semplice, spontanea e non riflessiva; lo dichiarava in una intervista al settimanale Gioia nel 1971 quando affermava: "Alle mie spalle non c'è la compatta filosofia di Dante e nemmeno il pessimismo integrale da cui partiva Leopardi. La mia parte è insieme più semplice e disperata": Affermazione che coglie il senso del pessimismo non pienamente eroico di Montale, ma di tipo stoico-borghese, che si sviluppa prima su di un piano prettamente cosmico e storico, per poi stringere e soffocare anche il soggetto mentre fa poesia; la poesia dell'intellettuale contemporaneo, frustrato, che vede ridotta o addirittura derisa la sua possibilità di intervenire e di riordinare il tutto.Ma Montale, al contrario dei Crepuscolari, non rinuncia al canto, ne' lo istituisce su ridotte ma vibranti certezze come Ungaretti. La sua negatività si traduce naturalmente in una dizione ascetica e incrinata, in una sensualità verbale che egli riconosce necessarie alla poesia moderna, sulla scia di una tendenza europea che ha inizi con Baudelaire, per la necessità di una forma espressiva capace di aderire alla frantumazione, alla sordidezza, all'inferno del vivere quotidiano. Baudelaire e Leopardi sono stati testimoni del nascere di una religione tecnica che ha sempre più preso piede e che Montale ha visto ingigantire. È possibile allora rapportare la tematica del "male di vivere" anche a questa condizione umana inserita all'interno di una società basata su principi tecnologici, di produzione e di meccanizzazione? Sarebbe errato, in quanto unilaterale, ricondurre il "male di vivere" di questi grandi poeti ad un'unica matrice; ma non si dovrebbe escluderla totalmente. Se consideriamo il nuovo moto di simpatia ideologica verso Leopardi e per chi come lui, quindi lo stesso Montale, ha espresso la sua concezione pessimistica della vita, e se consideriamo il momento storico-culturale in cui tale rivalutazione si è verificata, cioè il nostro tempo, in cui la religione tecnica è imperante in ogni campo, non si può non dedurre che forse, anzi, quasi sicuramente, esiste ed è rilevante tale motivazione al "male di vivere". Montale è più che mai, oggi, presente e vivo nel nostro pensiero e nella nostra sensibilità; ed è un metro di giudizio e valutazione, questo fatto, che ha una validità notevole nel nostro tempo che è caratterizzato da un clima culturale n cui il pensiero e la sensibilità sembrano essere fattori e risultati della moda. Tanti uomini, oggi, chi più consapevolmente, chi meno, chi più intensamente, sentono il disagio interiore e fisico, una disarmonia profonda nel vivere in una società che vorrebbe collocarli esistenzialmente in n sistema sociale basato su di un ordine artificiale che non tiene conto di tutto un mondo che è in realtà biologicamente frantumato, caotico, disordinato. Nel migliore dei casi questa disarmonia, questo disagio e questo sentirsi un relitto del mondo possono essere terreno fertile per il fiorire, in un deserto, di una ginestra gialla e profumata che, malgrado tutto, diffonda la sua fragranza, o, in un terreno bruciato, di un girasole "impazzito di luce", che "conduce / dove sorgono bionde trasparenze / e vapora la vita quale essenza",e per il nascere di quella grande poesia che è propria di Leopardi e di Montale.
|

 Il
senso di angoscia che ne deriva è il destino di chiunque, come Montale,
si senta diverso, inetto alla vita pratica, incapace di programmare
il proprio futuro, incapace di scegliere, estraneo all'ambiente; ed
è in questa inettitudine, in questo sentirsi estraneo al mondo in
cui vive, in questa sorta di avanguardismo malinconico, che Montale
si aggira nei pressi di un Crepuscolarismo arricchito da una spezzatura
tipicamente simbolista, ma di cui non condivide l'ironia e la polemica
del primo e la protesta fondamentale nel maledettismo simbolista.
Il
senso di angoscia che ne deriva è il destino di chiunque, come Montale,
si senta diverso, inetto alla vita pratica, incapace di programmare
il proprio futuro, incapace di scegliere, estraneo all'ambiente; ed
è in questa inettitudine, in questo sentirsi estraneo al mondo in
cui vive, in questa sorta di avanguardismo malinconico, che Montale
si aggira nei pressi di un Crepuscolarismo arricchito da una spezzatura
tipicamente simbolista, ma di cui non condivide l'ironia e la polemica
del primo e la protesta fondamentale nel maledettismo simbolista. Con
la fine dell'infanzia l'uomo deve dire addio al grembo protettivo,
in cui l'adesione al ritmo cosmico era spontanea e naturale. Il distacco
da quell'età mitica ("L'accolse la pastura che per noi più non verdeggia")
avviene con il "minuto violento" della consapevolezza che distrugge
ogni illusione. Quell'età perduta è possibile riviverla soltanto nella
dimensione della memoria. Quella montaliana è però una memoria difficile,
fatta di ricordi fulminei destinati subito a svanire, ad allontanarsi,
a diventare di un altro; è una memoria che cigola per un ingranaggio,
per un meccanismo non funzionante e non controllabile. Nonostante
questo, il ricordo è spesso un talismano che, per pochi istanti, può
introdurre l'uomo nel miracolo della salvezza; un miracolo, però,
avvertito, creduto, ma non reale e presto dimenticato. Tale oscillazione
tra memoria ed oblio venne confessata dal poeta stesso in seguito
alla scoperta di Proust che lo portava alla sensibilizzazione e all'approfondimento
di questo aspetto di carattere meramente esistenzialistico. Queste
le sue parole: "Io mi considero un uomo che vive dentro un mistero
ineffabile che continuamente lo tenta e non si lascia penetrare.
E la mia poesia è un diario intimo di questo uomo la cui esistenza
oscilla tra memoria ed oblio":
Con
la fine dell'infanzia l'uomo deve dire addio al grembo protettivo,
in cui l'adesione al ritmo cosmico era spontanea e naturale. Il distacco
da quell'età mitica ("L'accolse la pastura che per noi più non verdeggia")
avviene con il "minuto violento" della consapevolezza che distrugge
ogni illusione. Quell'età perduta è possibile riviverla soltanto nella
dimensione della memoria. Quella montaliana è però una memoria difficile,
fatta di ricordi fulminei destinati subito a svanire, ad allontanarsi,
a diventare di un altro; è una memoria che cigola per un ingranaggio,
per un meccanismo non funzionante e non controllabile. Nonostante
questo, il ricordo è spesso un talismano che, per pochi istanti, può
introdurre l'uomo nel miracolo della salvezza; un miracolo, però,
avvertito, creduto, ma non reale e presto dimenticato. Tale oscillazione
tra memoria ed oblio venne confessata dal poeta stesso in seguito
alla scoperta di Proust che lo portava alla sensibilizzazione e all'approfondimento
di questo aspetto di carattere meramente esistenzialistico. Queste
le sue parole: "Io mi considero un uomo che vive dentro un mistero
ineffabile che continuamente lo tenta e non si lascia penetrare.
E la mia poesia è un diario intimo di questo uomo la cui esistenza
oscilla tra memoria ed oblio": È
sull'esempio di Baudelaire e di Browning che Montale procede alla
divinizzazione del borghese, nell'assegnare, appunto, il proprio riscatto
ad un amuleto, oggetto colmo di presenze e di memoria, guardato con
un "regard familier". Ed è infatti baudeleriana la viva attenzione
al materiale inorganico, duro e lavorato, come le pietre preziose,
le stesse dei gioielli di Browning. Questa assunzione correlativo-oggettuale
porta naturalmente all'antropomorfizzazione espressionistica dell'oggetto.
Ma gli oggetti montaliani risultano più familiarmente carichi di ricordi
e di afetti personali, come il limone giallo, la cui immagine si concretizza
in modo vivace e preciso, in un'atmosfera semplice e schietta, come
gli occhiali di Xenia, con il loro riflesso caldo e affettuoso,
come il calzante perduto nell'albergo, così caro e bello anche e proprio
nel suo essere consumato dall'uso. Sebbene tanto diversi nei loro
modi e nelle loro pretese, Montale e Baudelaire, in modo non azzardato,
possono essere considerati simili nel loro tentativo di raggiungere
l'equilibrio, l'armonia propria della natura, di cui si sforzano di
trovare il senso profondo, l'uno (Baudelaire) convinto della sua esistenza,
tanto più divina, in una Natura-tempio ("Les Correspondances"), o
"foret de symboles", l'altro (Montale) in una spesso sconfessata speranza
che ci sia.
È
sull'esempio di Baudelaire e di Browning che Montale procede alla
divinizzazione del borghese, nell'assegnare, appunto, il proprio riscatto
ad un amuleto, oggetto colmo di presenze e di memoria, guardato con
un "regard familier". Ed è infatti baudeleriana la viva attenzione
al materiale inorganico, duro e lavorato, come le pietre preziose,
le stesse dei gioielli di Browning. Questa assunzione correlativo-oggettuale
porta naturalmente all'antropomorfizzazione espressionistica dell'oggetto.
Ma gli oggetti montaliani risultano più familiarmente carichi di ricordi
e di afetti personali, come il limone giallo, la cui immagine si concretizza
in modo vivace e preciso, in un'atmosfera semplice e schietta, come
gli occhiali di Xenia, con il loro riflesso caldo e affettuoso,
come il calzante perduto nell'albergo, così caro e bello anche e proprio
nel suo essere consumato dall'uso. Sebbene tanto diversi nei loro
modi e nelle loro pretese, Montale e Baudelaire, in modo non azzardato,
possono essere considerati simili nel loro tentativo di raggiungere
l'equilibrio, l'armonia propria della natura, di cui si sforzano di
trovare il senso profondo, l'uno (Baudelaire) convinto della sua esistenza,
tanto più divina, in una Natura-tempio ("Les Correspondances"), o
"foret de symboles", l'altro (Montale) in una spesso sconfessata speranza
che ci sia.